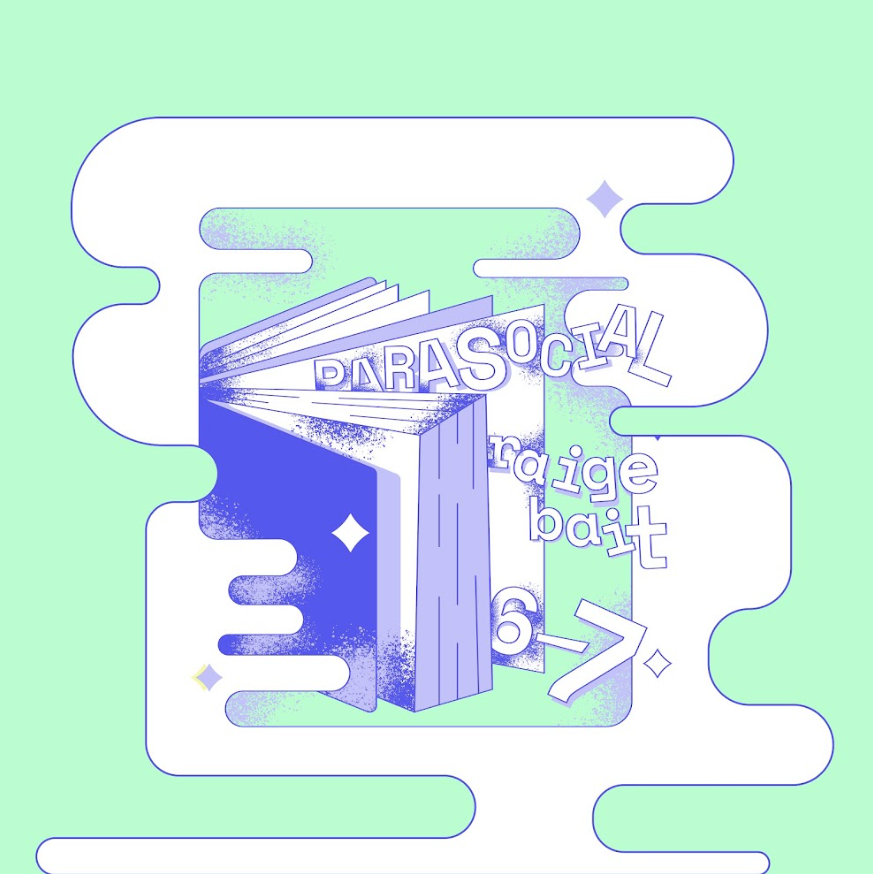Dicembre. Tempo di bilanci, algebrici per lo più, tra Q4 e forecast che non chiudono, ma allungano l’anno, all’infinito, con report, revisioni, conti pitagorici. E mettici pure la FOMO di fine anno, hashtag #ricordi o la mania dei Wrapped, che ci sbattono in faccia i nostri guilty pleasure – quel pezzo di Mina, che ti fa schizzare l’età a 89.
Se telefonando, sarà nostalgia? Canaglia, sì, ma alla fine siamo tutti un po’ ripetenti – praticamente bocciati, all’esame di matematica. Ok prof, lo diceva pure Venditti: non sarà mai il mio mestiere, ma oggi parliamo di letteratura. O meglio, di vocabolari, perché al revival di fine anno si aggregano pure nomi illustri: Cambridge, Oxford, Treccani… chi più ne ha, più ne metta. E allo scoccare della mezzanotte, o quasi, eleggono sua maestà: Cenerentola, la parola dell’anno.
Miss La parola dell’anno
Un autentico rituale lessicografico, che va avanti dal 1971, quando la Società per la lingua tedesca scelse aufmüpfig – ribelle, testardo, ostinato – come parola dell’anno. Certo, non un caso: nello stesso arco, uscivano i Rolling Stones con Sticky Fingers – e ostinarsi, col rock della prima ora, aveva un senso, ma oggi… sembra solo routine. Così, da una bella idea, ecco un’abitudine consolidata – ammuffita, meglio dire, tant’è che l’anno scorso il grande Dictionary si è arreso all’inutilissimo brainrot, parola dell’anno.
E se il 2024 fu l’annata della muffa cerebrale, quest’anno tocca alla fuffa. Sì, perché per il 2025 i dizionari anglofoni hanno voluto deliziarci con un’altra sfilza di parole non-parole a dir poco inutili – e se la storia insegna, come brainrot, ne sentiremo parlare ancora per poco. E allora, scaraventiamoci in questa rassegna delle peggiori non-parole dell’anno. Preparatevi: noi vi abbiamo avvisati.
La grande fiera della parola inutile
Partiamo dal vertice della classifica – inferiore, probabilmente. Già, perché l’oro (o meglio, l’horror) quest’anno se lo prende il Dictionary.com, pietra miliare del lessico US, che se ne viene fuori con six-seven, 6/7.
Dicevamo, l’algebra, ma la frazione è inutile – sì, perché 6/7 non significa n-i-e-n-t-e. Non è un nome, non è un intercalare, manco un riempitivo, e forse neanche un meme. E il Dictionary, poveretto, deve rendere conto di un certo imbarazzo quando lo definisce “termine ambiguo e largamente insensato”. Ma ci pensiamo noi, caro vecchio dizionario: 6/7 viene da Skrilla – se avete capito Skrillex, siete già fuori target – un rapper di Philadelphia che pronuncia 6 e 7 in una barra, in modo un po’ cantilenante. Stop. E tanto è bastato per farne un trend, al Dictionary per farne la parola dell’anno.
E se non bastava l’algebra, ecco l’informatica. Con il Collins Dictionary, britannico, in una bella partnership con qualche tech corporate – altrimenti non ci si spiega perché, tra mille possibilità, abbia scelto proprio vibe coding, parola che descrive un approccio “intuitivo” all’uso dell’IA. Nome cool, di quelli che possono mettere d’accordo chill bro invasati di lo-fi e svariati nerd programmatori. Peccato che sotto la patina cool, ci sia una verità assolutamente sdoganata: vibe coding spiega l’impiego medio(cre) dell’intelligenza artificiale, di fatto a sentimento, senza competenze, senza metodo. Un modo educato per non dire “ad minchiam”, espressione che certo avremmo accettato, senza controbattere. E invece, il Collins si ostina a dar nome a una banalità – davvero, scopriamo solo nel 2025 che usiamo la tecnologia “a sentimento”? Beh, a quanto pare in Inghilterra hanno scoperto ChatGPT prima dell’acqua calda.
Ma non finisce qui. Il Cambridge punta tutto su parasocial, udite udite, una parola che descrive le relazioni fittizie – quindi paranoiche – che instauriamo con creator, influencer, celebrities, chiaramente non corrisposte. Beh, come a dire che si doveva aspettare il 2025 per capire che le celebrità, dal loro Olimpo, si curano di noi solo in termini di community, numeri, dati e report. Insomma, complimenti a glottologi e antropologi di Cambridge: esperti, a quanto pare, nell’arte (ig)nobile di vendere l’acqua calda – ma ben impaginata, eh.
Dulcis in fundo: il rage bait, per l’Oxford Dictionary. Termine ombrello – piove spesso, lassù – per tutti quei contenuti creati, diffusi, condivisi col solo fine di generare indignazione. Polarizzare, monetizzando sulla rabbia. Ma a noi fa tristezza, sapere che un grande dizionario scopre solo oggi l’esistenza delle fake news – del click baiting, del brand beefing, di tutte le esche dell’engagement che puntano sempre e solo sulla nostra rabbia. Davvero, cari anglosassoni, serviva ricordarci che internet ci rende più aggressivi? O bastava leggere i commenti sotto qualsiasi post dal 2010 in poi?
Abbiate fiducia, in Treccani
Bene, fin qui la tempesta – la fuffa, quanto si concentra, sa essere dirompente. Ma le nubi si dipanano in Italia, per una volta. Lasciamo correre il maltempo britannico, o i tifoni americani, perché Treccani ci regala un raggio di luce: una parola, fiducia.
Niente slang, niente urban, niente fuffa lessicale: nessuna corsa alla marketizzazione dei dizionari, che inseguono parole trendizzate come influencer in crisi da pandoro. Perché Treccani, da autorevole dizionario, sceglie una parola antica, limpida, carica di senso. La fiducia, che non descrive un effetto collaterale dell’algoritmo o un’abitudine passeggera, ma una condizione umana. Una promessa, più che una diagnosi.
Perché in un mondo che cambia a scatti, tra flash news e codici linguistici della durata di un OTP, non sempre serve un neologismo per capirci. A volte, sono proprio le parole comuni, il linguaggio che già abbiamo a offrirci un rifugio dalla grande Babele dei linguaggi. E in tutti questi cambiamenti, che facciamo fatica a comprendere, ci vuole proprio fiducia per capirci ancora qualcosa – e soprattutto per capirci, tra di noi.