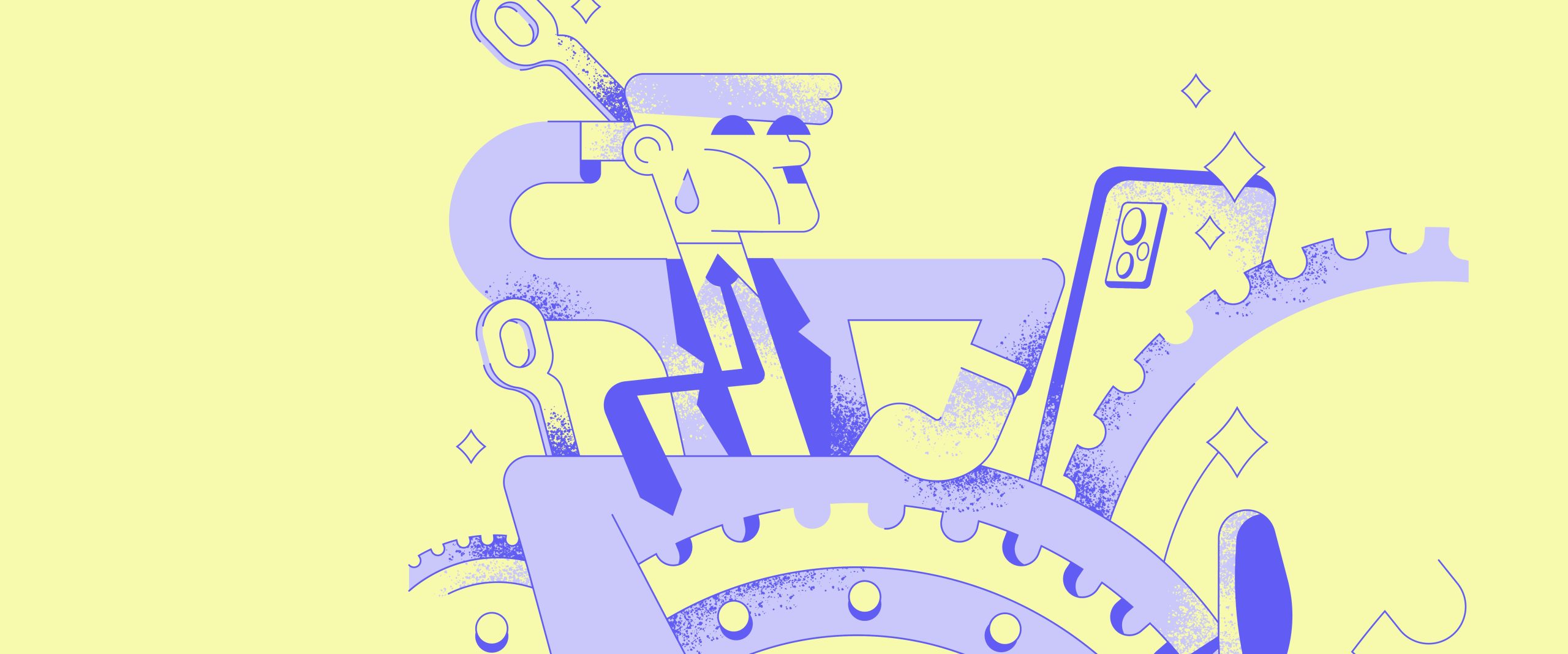Sapere aude, dicevano gli antichi, ma attenzione: non tutta la cultura è un bene. Non volercene, Voltaire: non stiamo rievocando le ombre dei tabù – col favore delle tenebre, ai giorni d’oggi, ci lavorano in troppi. Ma occorre far luce, guarda un po’, proprio su presidenti, manager e alte cariche, evangelisti di una cultura che ha i connotati di un credo: tossica, perversa, patologica, va di moda chiamarla hustle culture, letteralmente, cultura della fretta. In America si scopre ora, ma la saggezza popolare, invisa agli illuministi, ci aveva già insegnato a distinguere tra lavorare per vivere, e vivere per lavorare – ahinoi, la memoria è corta.
Che fretta c’era?
Ai tempi di Musk, non è difficile trovare profeti di questa mentalità. Proprio al papa (senza accento) di Tesla, si imputa la famosa omelia: “nessuno può cambiare il mondo, lavorando solo 40 ore a settimana” – lo stesso del sacco a pelo, ricordiamocelo, che orgoglioso spendeva la notte in ufficio per risparmiare minuti, sul tragitto casa-azienda. Poco, straordinariamente, in confronto a Marissa Mayer, CEO di Yahoo, che ostentava le sue 130 ore lavorative settimanali – per capirci, 18 e mezza al giorno, sabato incluso. Ma tanto basta, la personalissima vicenda di Sua Santità, per definire l’ABC della cultura della fretta: più lavori, più corri, più meriti. E certo è difficile restare sobri, nell’euforia lavorativa.
Workaholic? Non proprio. L’alcolismo lavorativo esiste già dal 1971, quando il termine, dispregiativo, si usava per screditare l’eccesso come una follia – 50 anni dopo, ecco la cultura della fretta, postuma. Ma i postumi non li abbiamo smaltiti, perché se il workaholic annegava, decadente, nella sua sbornia solitaria, la hustle culture degli anni ‘20 è invece una grande festa celebrativa, eroica, redentrice, che vive il tempo lavorativo come liberazione, l’ozio come schiavitù. Testimone un hashtag, per citare un esempio, come #thankgoditsmonday – grazie a dio è lunedì, finito il weekend degli sfaticati!
Ma per fortuna, di nuovo, la cultura popolare ci ricorda che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. E i figli, della hustle culture, sono accecanti: come il burnout, fumo negli occhi, tanto sdoganato quanto ancora tabù – specie se 8 italiani su 10 ne accusano i sintomi. E se dal COVID a oggi non ne siamo ancora usciti, vorrà dire che il problema è culturale. C’è bisogno di scavare.
Slow down!
E andiamo giù, allora, nei meandri delle statistiche, per riscoprire una verità elementare: l’eccesso lavorativo fa male – pensa un po’ come stiamo messi. Dicono gli studi, che il work-stress compromette il lavoro: la produttività decresce, drasticamente, oltre le 50 ore settimanali. Ma come? Il lavoro che ci libera, nella profezia muskiana? Quel lavoro che, si diceva, nobilita l’uomo? Beh, non ne faremo una Rivoluzione Francese, ma certo non ci piacciono i titoli – men che meno il sangue blu, che non giova alla salute. Ma una battaglia sì, la combattiamo volentieri: contro l’eccesso di lavoro, anche perché, se esiste il troppo, ci sarà pure un giusto mezzo.
Lo incontriamo a metà strada: contro i sermoni di CEO, manager, velocisti che alimentano la fretta, noi siamo affezionati a una semplice, lapidaria constatazione: quantità non è qualità. Certo, con poco non si fa nulla, ma abbondanza non è sinonimo di valore. E mica lo diciamo solo noi eh, che un trend su tutti ci dà sostegno: la break culture, risposta ovvia all’ansia di accelerare.
Di nuovo, non ci voleva la scienza, ma contro gli scettici la citiamo volentieri: chi si prende pause, durante la giornata lavorativa, mantiene una produttività superiore del 13% rispetto ai lavoratori non-stop. E allora smettiamola di confondere “troppo” con “meglio” – lo dice la saggezza popolare, e volentieri la citiamo, che il troppo stroppia.
Velocisti, un consiglio: staccate. Se proprio ci deve essere una cultura del lavoro, non ce la faremo predicare dai santoni – la cultura, in ogni caso, non è un credo.